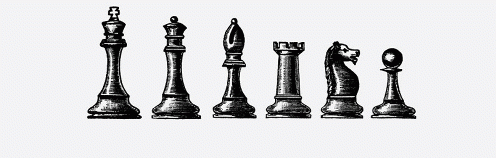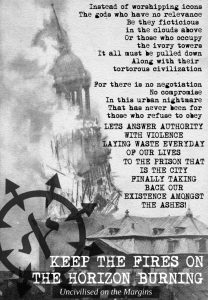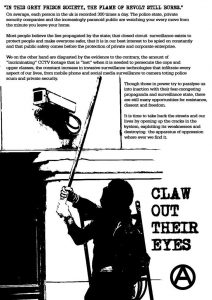riceviamo e diffondiamo:
E’ uscito il libro di Yves Pages “Liabeuf, l’ammazzasbirri”.
136 pagine – 8 euro, per richieste di almeno 5 copie il prezzo è di 5 euro.
Info e richieste a: liabeuf1910ATgmailDOTcom 
A Roma potete trovarlo alle librerie: Rebel Store San Lorenzo e L’ Idea al Pigneto
Di seguito l’introduzione:
La Storia è una sorta di museo dove, appena vi si mette piede, si viene presi in consegna da guide specializzate che conducono in visita nelle diverse sale; illustrano le gesta di re, papi, nobili, politici, facoltosi personaggi; mostrano i ricordi di coloro che furono protagonisti di guerre, di conquiste, di invasioni; informano sulla nascita e sul crollo di Imperi e di Stati. Perché la Storia è essenzialmente un museo dedicato alla dinastia del potere, alla sua gloria, organizzato a sua immagine e somiglianza.
Solo in poche sale, spesso chiuse al pubblico, sono reperibili i segni di parte di quell’umanità che si è ribellata all’autorità e l’ha combattuta nel corso di sommosse o rivoluzioni. Qualora la dimensione dei fatti sia stata eclatante, non si può fare a meno di riservarle un piccolo spazio. Ma, laddove è possibile, tutto ciò che non ricorda ai visitatori l’obbligo eterno dell’obbedienza andrà a finire negli scantinati bui dell’edificio. Sepolto e dimenticato. Mai esistito.
Ciò spiega bene il motivo per cui, giudicato sconveniente ed epurato dai custodi della Storia, il nome di Jean-Jacques Liabeuf sia stato tramandato dalla letteratura. Ieri a salvarlo dall’oblio furono i versi del surrealista Robert Desnos, che mai scordò l’emozione provata da bambino, quando gli capitò di assistere all’arresto del «vendicatore coi bracciali di acciaio» (vivendo per di più nello stesso rione). Oggi a riproporne la memoria è quest’opera di Yves Pagès, dal sapore un po’ da feuilleton, apparsa in Francia nel 2001 a cura delle edizioni Insomniaque. È un merito che giustifica la sua pubblicazione in italiano, facendoci superare anche l’allergia nei confronti della diffusa mania di romanzare il passato più eccitante. Sotto il mantello della mitopoiesi, o dell’affabulazione, troppe volte si nasconde la più squallida mercificazione della rivolta: frugare fra le ossa dei ribelli morti, fra i loro resti, alla ricerca di cimeli originali da piazzare su un mercato editoriale saturo di banalità.
Ma Liabeuf non era un teorico, né un agitatore. Non ha lasciato dietro di sé nessun fiume di parole da poter raccogliere, catalogare, commentare. Tanto meno è stato un bandito o un guerrigliero, con una vita piena di avventure da mitizzare. Niente di tutto ciò. Nel 1910 è stato il protagonista di un fatto di cronaca nera che ha suscitato scalpore in Francia. La vendetta di un semplice operaio contro la polizia che ne aveva infangato la dignità, accusandolo e facendolo condannare per sfruttamento della prostituzione.
L’individuo contro lo Stato finirà com’è abbastanza prevedibile, sulla ghigliottina. Ma non prima che la sua vicenda diventi un caso pubblico, sollevando aspri dibattiti sui metodi polizieschi e arroventando gli animi.
A Parigi la notte dell’esecuzione, mentre la lama scendeva sul collo di Liabeuf, trentamila manifestanti si batterono furiosamente contro l’infame sbirraglia. Il suo nome sulle labbra.
Questo libro narra quindi una storia che non c’è più, che è andata persa. Anzi, che è stata demolita. Basti pensare ai quartieri popolari abitati da una popolazione povera, ma orgogliosa: la Montmartre «del piacere e del crimine», Les Halles, Belleville, Pantin, Aubervilliers, Clichy… Come ricorderà Victor Serge, «uno dei caratteri particolari della Parigi operaia di quel tempo, era che si trovava a contatto in vaste zone con la teppa, cioè col vasto mondo degli irregolari, dei decaduti, dei miserabili, col mondo equivoco». Le cosiddette classi pericolose erano composte non solo da operai e artigiani in regola, ma anche da tutto un sottobosco di ladri, rapinatori, borseggiatori, truffatori, falsari, prostitute. Un anno dopo la morte di Liabeuf, in occasione della comparsa di Bonnot e dei «banditi tragici», un quotidiano parigino lamenterà la presenza in città di 200.000 fuorilegge su una popolazione di tre milioni di abitanti. Solo gliapache, gli appartenenti (il più delle volte minorenni) alle bande di strada, venivano contati in 30.000 elementi. Si tratta di stime forse esagerate, ma che rendono bene l’idea di come la Parigi mondana e la Parigi sotterranea fossero due mondi davvero distinti e contrapposti. Fra il borghese e il proletario non v’era alcun rapporto dialettico, alcun confronto pacato, alcun dialogo costruttivo. C’era guerra, guerra sociale. Trovandosi a combattere dalla stessa parte della barricata, a vivere nei medesimi quartieri, operai e teppa erano legati da un medesimo «spirito di classe» e da un forte sentimento di solidarietà. Nonché, soprattutto, da un odio viscerale per la sbirraglia. Un odio arcaico che non rischiava di estinguersi, trovando modo di rinnovarsi quotidianamente.
In quegli anni, sotto il pugno di ferro di Georges Clémenceau, che da simpatizzante rivoluzionario era diventato «primo sbirro di Francia», ogni forma di disobbedienza e rivolta veniva repressa brutalmente. E mentre la polizia dava la caccia a tutti i criminali e i sovversivi, l’esercito non esitava ad aprire il fuoco sui manifestanti. Molti scioperi e rivolte finirono con veri e propri massacri: a Perpignan (giugno 1907), a Raon-l’Etape (luglio 1907), a Draveil (maggio 1908), a Vigneux (giugno e luglio 1908), eccetera. Non ci potevano essere dubbi, chi indossava una uniforme veniva considerato esattamente per quello che era: un sicario al servizio del potere.
È questo il mondo andato perduto, annientato. L’urbanistica ha via via ripulito il centro delle città dalle classi pericolose per scongiurare l’alchimia dei loro incontri sediziosi. Una volta sostituite le botteghe disordinate con eleganti boutique, o le taverne fumose con rilaccati restaurant, ristrutturati gli edifici e rincarati i prezzi degli affitti, le strade di quei quartieri si sono svuotate della fauna selvaggia dei loro abitanti storici per riempirsi di onesti cittadini benpensanti — vero cancro della vita moderna. E questo intervento repressivo non poteva limitarsi agli spazi fisici, ma doveva prendere di mira allo stesso tempo anche quelli mentali. Ai costumi, alle usanze, allo stesso linguaggio, è stato inoculato il veleno del conformismo sotto forma di senso civico. L’essenza recalcitrante è stata soppiantata prima dall’integrazione, poi dalla partecipazione. Agli operai è stato insegnato che il lavoro nobilita e rende liberi, presupposto per guardare con occhi pieni di gratitudine i padroni che lo offrono nonché per scavare un abisso di distanza da quei “parassiti” che lo evitano. Non solo, è stato loro insegnato che queste presunte nobiltà e libertà sono messe a repentaglio da qualsiasi turbamento dell’ordine sociale. Da qui a passare dalla parte della polizia, il passo è breve.
Se già mezzo secolo fa André Salmon faceva rientrare il caso Liabeuf in una di quelle «storie precedenti la Prima Guerra; non le si capiscono più molto bene, adesso», figuriamoci oggi! Ai giorni nostri siamo talmente abituati a vivere in metropoli asettiche, disegnate per venire incontro alle esigenze della merce e del controllo sociale, attraversate da consumatori-telespettatori rispettosi della legge, da non riuscire più nemmeno ad immaginare altro. Un centro cittadino abitato da operai e teppa uniti dall’odio verso il nemico in uniforme, con i sovversivi (a loro volta metà operai e metà teppa) pronti a soffiare sul fuoco della rivolta in ogni occasione — tutto ciò esprime un mondo diventato letteralmente impensabile. Come i sentimenti che lo permeavano.
«Odio infinitamente perché amo senza riserve», urlava un anarchico della metà dell’Ottocento. All’inizio del Duemila si odia relativamente, perché si ama con molte precauzioni. Ecco perché un gesto come quello di Liabeuf può apparire mostruoso. Perché gli esseri addomesticati non riescono più a comprendere la furia di chi è indomito. La guardano con sospetto, con una smorfia a metà tra il timore e il disprezzo. Non comprendono come un cuore offeso possa attuare la Vendetta e non invocare la Giustizia (e vendetta “alla cieca”, nemmeno compiuta sui diretti responsabili, ma colpendo nel mucchio dei loro colleghi!). Non lo comprendono perché non hanno più cuore.
Un giovane artigiano, abile ciabattino, proletario orgoglioso di sé, s’innamora di una prostituta. I poliziotti della buoncostume lo accusano di esserne il protettore. Sanno di mentire, ma vogliono dare una lezione a quella testa che non si abbassa al loro cospetto. A nulla varranno in tribunale le dichiarazioni della ragazza, del giovane artigiano, di chi lo conosce, nemmeno il suo datore di lavoro sarà creduto. Come sempre accade, per il giudice fa fede la parola dei poliziotti. E condanna il ciabattino. La Società decreta pubblicamente che Jean-Jacques Liabeuf è un volgare magnaccia.
Il suo cuore esplode di rabbia per questa umiliazione. Allorché esce di prigione, un solo pensiero prende possesso della sua mente. Non si rivolge all’opinione pubblica, non fa scioperi della fame, non invia lettere di protesta alle autorità competenti, non fa presidi davanti ai tribunali, non si suicida per la vergogna. Ma pianifica la sua terribile vendetta. Si costruisce dei bracciali e dei paraspalle appositi, irti di punte d’acciaio per tenere a bada la stretta degli sbirri (che all’epoca giravano disarmati, contando solo sulla forza dei loro muscoli), si procura un’arma e va a caccia di coloro che hanno calpestato la sua dignità. Non trovandoli, se la prenderà coi loro colleghi. Ovvero con chi ha sicuramente mortificato qualcun altro o, nel migliore dei casi, è quotidianamente complice di simili nefandezze. Sono stati gli sbirri ad averlo immerso nel fango insudiciando il suo amore, sono gli sbirri che lui vuole annegare nel sangue. Ed è quello che farà. Così Liabeuf prova «l’inebriante gioia della vendetta soddisfatta».
Tutto ciò non ha nulla a che vedere né con la legge del taglione, né con la Giustizia. La vendetta è un fatto privato, individuale, non sa che farsene delle sciocche convenzioni sociali con cui si pretende di regolare la vita degli esseri umani. Il cuore che sanguina non misura il proprio dolore col bilancino del farmacista. Pensare di consolarlo infliggendo una ferita analoga a chi lo ha offeso è calcolo da ragionieri, è ancora un tentativo di imporre un equilibrio a quanto di più eccessivo vi sia: la libertà umana. Seguendo il biblico «occhio per occhio, dente per dente», cosa avrebbe dovuto fare Liabeuf? Calunniare e denunciare a sua volta gli sbirri per cercare di farli condannare a qualche mese di prigione? Anche se vi fosse riuscito, ciò avrebbe significato mettersi sullo stesso livello, diventare come loro — un infame.
La Giustizia è una pura astrazione, è solo un modo per mettere ordine nei rapporti umani. Un formalismo inventato per (im)porre fine ai conflitti che possono nascere fra individui evitando che mettano a repentaglio la pace dei mercati e l’ordine nelle strade, quel che la propaganda definisce «convivenza civile». La convenzione chiamata Giustizia sottrae all’arbitrio individuale la decisione di cosa fare dinanzi ad una offesa ricevuta. Non è più l’essere umano concreto, in carne ed ossa, a reagire. Al suo posto interviene l’istituzione che, con il pretesto di disinnescare il rischio di una reazione a catena (faida), stabilisce una norma di comportamento cui tutti devono adeguarsi e al tempo stesso ribadisce il proprio monopolio della forza.
Se è palese che la Giustizia serve esclusivamente gli interessi di chi scrive le sue leggi, dello Stato, lo è molto meno la constatazione che essa sarebbe odiosa in qualsiasi circostanza, anche se a riportare la calma fra individui fosse un altro feticcio collettivo (la famiglia, l’assemblea, il partito, la comunità, il gruppo). Probabilmente non è un caso se anticamente con la parola vindicta si indicava la verga con cui si toccava lo schiavo che doveva essere posto in libertà. Perché grazie alla vendetta lo schiavo torna ad essere libero, si reimpossessa del libero arbitrio. Non delega a niente e a nessuno la risoluzione dei propri conflitti, li affronta in prima persona assumendosene la responsabilità. Ciò può apparire terribile, tipico della «legge della giungla», solo a chi ha introiettato la legge dello Stato al punto da considerarla unica misura dei rapporti umani. Ovvero, a chi non si rende più conto che la libertà assomiglia effettivamente molto più a una giungla piena di insidie che ad un convento in cui si prega e si lavora allo scopo di spegnere ogni passione.
Ecco perché la storia di Liabeuf non fa parte della Storia. Perché il singolo individuo che si vendica deve scomparire di fronte alla Società che fa giustizia, come la libertà deve scomparire dinanzi all’autorità. È solo grazie all’abitudine alla Verità di Stato che chiunque indossi un’uniforme può oggi intimidire, molestare, picchiare, stuprare, torturare, uccidere, massacrare… e dormire sonni tranquilli. Sonni che si spezzeranno solo quando il ricordo del vendicatore coi bracciali di acciaio uscirà dalla finzione letteraria per andar loro incontro cantando al ritmo di una giava.
A Parigi, all’inizio del secolo scorso, l’anarchico Albert Libertad domandava dalle pagine del suo settimanale: «l’agente che ammazza e che mente non gioca con il fuoco quando fa gravare pesantemente il suo stivale di bruto sul cervello di quelli che pensano e ragionano? L’agente che uccide e calunnia non teme affatto il ferro, mentre stritola con le sue mani di nullafacente le braccia di quelli che lavorano e producono? Questo simbolo dell’autorità abietta troverà sempre davanti a sé dei rassegnati?».
Un paio di anni più tardi, questo interrogativo troverà nel ciabattino Liabeuf la sua risposta. Una risposta che oggi, purtroppo, tarda ad arrivare.