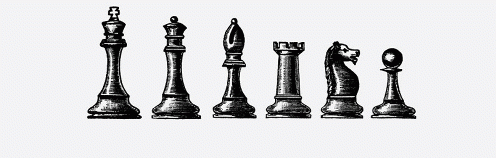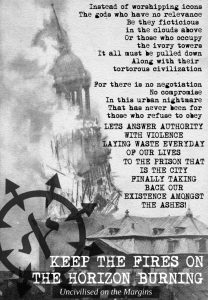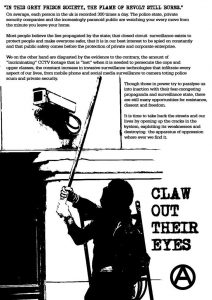A quanto pare il femminismo militante sta tornando in auge. Sulla carta, perlomeno. Fosse avvenuto alcuni anni fa, avrebbe magari fatto da profilassi o almeno da antidoto a quella putredine di movimento che ci ha avvelenato prima con un opuscolo contro l’aborto (scritto da una donna e pubblicato da una casa editrice anarchica) e poi con uno stupro di gruppo (all’interno di una sede antifascista), secrezioni che hanno conosciuto entrambe l’indifferenza attiva di più kompagni e kompagne. Comparendo solo oggi, si limita per ora a lasciar intendere di fare domani ciò che non si è stati in grado di fare ieri. Quando l’intenzione è buona, la coscienza è salva.
A quanto pare il femminismo militante sta tornando in auge. Sulla carta, perlomeno. Fosse avvenuto alcuni anni fa, avrebbe magari fatto da profilassi o almeno da antidoto a quella putredine di movimento che ci ha avvelenato prima con un opuscolo contro l’aborto (scritto da una donna e pubblicato da una casa editrice anarchica) e poi con uno stupro di gruppo (all’interno di una sede antifascista), secrezioni che hanno conosciuto entrambe l’indifferenza attiva di più kompagni e kompagne. Comparendo solo oggi, si limita per ora a lasciar intendere di fare domani ciò che non si è stati in grado di fare ieri. Quando l’intenzione è buona, la coscienza è salva.Ma l’intenzione, è davvero buona? Me lo domando. Ho davanti agli occhi un manifestino affisso in alcune città italiane per mettere alla gogna uno stupratore. Ci vedo sopra il suo nome, il suo volto e il marchio dell’infamia. Nient’altro, non un accenno di spiegazione. Dietro invece ci vedo come minimo un’ammissione di debolezza. Non capisco, forse preferisco non capire. Ma non posso fare a meno di domandarmi cosa si sia diventati per far pesare su uno stupratore non la folgore della verità, ma l’ombra del sospetto. In un deserto di consapevolezza, un nome e un volto basteranno al risentimento per aizzare il branco. Ma l’odio vuole le sue ragioni. E pazienza se superano i 140 caratteri.
Piuttosto, supera quasi le 300 pagine il nuovo libro uscito da poco, quello sulle Rote Zora, al cui interno non ho dubbi di trovare le ragioni dell’ostilità verso chi sfrutta, umilia, molesta, stupra le donne. Qui, fra le parole e le pratiche di quel vecchio gruppo tedesco di donne arrabbiate, donne che per una ventina d’anni reagirono a mano armata contro l’oppressione. Non erano anarchiche? Poco importa! Non è stata certo la mancanza di slogan o simboli libertari sui loro volantini ad impedire alla rivista Anarchismo, cui ho dato anche il mio contribuito, di tradurre e pubblicare qui in Italia, nel lontano 1985, prima un loro comunicato e poi la loro nota intervista «La resistenza è possibile». Era più che sufficiente il fatto che le Rote Zora si distinguessero, sia nella scelta del nome che nello stile dei comunicati, dai lugubri ritornelli degli aspiranti dittatori del e sul proletariato. Al di là delle ovvie divergenze, la loro è stata un’esperienza meritevole d’essere conosciuta e ricca di spunti interessanti su cui riflettere. Non caddero nella tentazione — assai forte in quegli anni — dell’organizzazione verticistica con tanto di specializzazione armata. Non fecero della clandestinità una norma rivoluzionaria. Non si separarono dalle lotte sociali. Non fecero del patriarcato né il loro unico nemico, né lo spauracchio da sostituire. In un periodo di riflusso, paura e desistenza, proposero e praticarono l’attacco diffuso. Mentre apro il libro, affiorano piacevoli ricordi.
Mi areno però al termine dell’introduzione di questo libro, desolata, incupita, in preda alla medesima domanda: è davvero buona l’intenzione? Oppure quest’ultimo titolo su un vecchio gruppo di lotta armata buono per tutti i palati (nell’editoria della composizione vanno bene i Gruppi Autonomi spagnoli, vanno bene i Gari, vanno bene le Rote Zora, manca la George Jackson Brigade dalla doppia anima autoritaria e anti-autoritaria — ma prima o poi, ne sono certa, arriverà anche il suo turno) è solo il pretesto per infliggerci l’ennesima «narrazione» cretinizzante condita con espressioni prese a prestito dal pensiero accademico post-qualcosista? Qui, ed è la gran bella novità di cui davvero non si avvertiva la mancanza, non si sollevano solo gli spifferi dell’ideologia rivoluzionaria autoritaria, ma pure il mulinello del fondamentalismo femminista anti-eterosessuale. Povere Rote Zora, non se lo meritavano…
Altri ricordi, meno piacevoli, mi tornano ora alla mente. Nella seconda metà degli anni 70 il femminismo “storico” — nonostante mi ci fossi pure impegnata, con tanto di partecipazione ad incontri di autocoscienza collettiva, manifestazioni separatiste e quant’altro — non ci aveva messo molto ad annoiarmi ed irritarmi a morte. Trovavo disgustoso il suo palese collaborazionismo di genere (la sorellanza secondo cui bisognava accettare al proprio fianco e confrontarsi rispettosamente con qualsiasi carogna purché vaginodotata) e ridicolo il suo malcelato integralismo di genere (secondo cui ogni contatto con un uomo rende impure). L’aria fra le femministe dell’Autonomia era molto più respirabile, ma anche lì era viziata da un equivoco di fondo che ritengo abbia avuto un peso nel legare strettamente il femminismo al carro della sinistra, moderata o estrema: pensare che il problema dell’autoritarismo consista in chi lo esercita (nella sua appartenenza di classe o di genere), anziché nel potere in sé. Non sono mai stata d’accordo. Così come è il potere di classe in sé a dover essere distrutto (lo Stato borghese non va certo sostituito con quello operaio), allo stesso modo è il potere di genere in sé a dover essere distrutto (il patriarcato non deve affatto essere sostituito con qualsiasi altro “arcato”, matriarcato in testa). So bene che gran parte degli uomini sono dei veri pezzi di merda ma, se è per questo, so pure che gran parte delle donne sono delle perfette stronze. Questo perché siamo tutte e tutti modellate e plasmati dall’ordine dominante, che ci insegna e ci obbliga a rispettare le sue leggi, le sue norme, i suoi ruoli, e ad identificarci nei suoi stereotipi. Per me la liberazione è un divenire che comincia con la diserzione da queste imposizioni, col loro rifiuto, non con la loro inversione o con il loro attraversamento. Ai miei occhi la miseria del femminismo 3.0 consiste proprio nel sostenere il dovere di questa inversione e questo attraversamento. Poiché la maggioranza degli uomini e delle donne non lo assolvono, vengono additati colpevoli di eterosessualità — considerata un immobilismo affettivo e carnale sintomo di complicità con l’oppressione — ed in quanto tali esclusi dalla vera liberazione sessuale che diventa così appannaggio delle sole minoranze sessuali (e nemmeno di tutte, sia chiaro, giacché certe “perversioni” sgualcirebbero la rispettabilità della causa LGBT).
Tralascio ridicole pretese come quella di conoscere i segreti dell’alcova altrui, riflesso dell’interiorizzazione della fine della riservatezza (a sua volta frutto della perenne condivisione online della propria vita, imposta via via dal dominio tecnologico), o come quella di ritenere che l’inclinazione sessuale sia di per sé significativa di qualcosa. Ma se già è inaccettabile che la maggioranza quantitativa di una inclinazione sessuale venga eletta a norma, decretando così l’aberrazione qualitativa delle minoranze, lo è altrettanto il puerile espediente difensivo messo in atto da queste minoranze: fare dell’appartenenza alla maggioranza una colpa oggettiva. Al largo, più al largo possibile dal demenziale delirio di una guerra civil-sessuale, dove l’astio per gli «sporchi omosessuali» fomenta l’astio per gli «sporchi eterosessuali», la diserzione dai ruoli si offre alla portata di ogni singolo individuo quale che sia il suo cromosoma, la fonte del suo piacere ed il nome del suo amore. Ma mi rendo conto che si tratta di una aspirazione mia e di pochi altri esseri umani.
Non mi pare sia la stessa di chi ha curato questa antologia delle Rote Zora. Prima riga dell’introduzione: «Rote Zora è una rete di gruppi composta da donne e lesbiche che ha portato…». Stropiccio gli occhi, convinta ingenuamente che si tratti di un refuso. No, non lo è, dato che verrà ripetuto fino allo sfinimento ovunque possibile. Donne e lesbiche? Quindi le lesbiche… non sono donne! Non conoscevo questa interpretazione (presumo ereditata da Monique Wittig, teorica femminista lesbica francese accasciatasi appena ha potuto sulle cattedre statunitensi), forse introdotta dopo la mia breve esperienza nel circuito femminista, ma trovo che presenti due aspetti alquanto discutibili. Il primo, di colore se così si può dire, è che in questa maniera viene specularmente confermato l’antico luogo comune maschilista secondo cui gli uomini, i «veri» uomini, quelli «sani», quelli «normali», sono soltanto quelli che amano le donne; gli altri, quelli che si amano tra di loro, non meritano di essere considerati uomini (preso atto di ciò, resta solo da scegliere se trasudare grettezza definendoli «finocchi», o se ostentare correttezza politica definendoli «gay»). Le curatrici di questa edizione sembrano pensarla allo stesso modo, pur rovesciandone la prospettiva: sono le donne a non essere degne di essere considerate lesbiche (qui però un dubbio mi assale: ma gli esseri umani col doppio cromosoma X la cui sessualità non desidera né Priapo né Saffo, come vanno definiti?).
L’altro aspetto, assai più importante, è che questa distinzione fra donne e lesbiche sarà anche una consuetudine all’interno del movimento femminista odierno, ma di certo non veniva adottata dalle dirette interessate, ovvero le aderenti a Rote Zora, le quali — forse perché a salutare digiuno di teorie universitarie yankee radical chic — si consideravano semplicemente donne (alcune lesbiche, altre etero). Il problema accennato nell’introduzione del libro, quello generato dalla lingua tedesca — per cui le parole «donna», «madre» e «moglie» hanno una medesima e quindi odiosa matrice —, che costringeva le Rote Zora ad usare il termine «donna-lesbica», in italiano non si pone. Anzi, erano loro stesse a dolersi del fatto che questa definizione «può dare l’impressione che le lesbiche non siano donne», così come erano consapevoli che «la continua ripetizione di chi siamo e da dove proveniamo ha rischiato di trasformarsi in sigillo identitario che consegna le categorie sociali all’immodificabilità biologica, da cui non esiste via di scampo». Dunque, perché mai introdurre una differenziazione che non esisteva nelle teste di quelle compagne tedesche? Perché così è più facile trasformare la lotta delle Rote Zora contro il patriarcato nella lotta contro l’eteropatriarcato invocata dalle loro editrici italiane?
Personalmente trovo assai fastidioso imporre al chiaro passato ribelle altrui le proprie griglie interpretative, soprattutto quando queste sono rifornite dal presente istituzionale più fessoterico. Per le curatrici del libro si tratta probabilmente di correggere ed aggiornare le Rote Zora, prestando loro nuovi significati inediti all’epoca e che — qualora li avessero conosciuti — non avrebbero potuto fare a meno di condividere; ma per me si tratta di pura manipolazione, di impoverire una esperienza vivente prosciugandola del senso originale assegnatole da chi l’ha vissuta direttamente, per contrabbandarne uno a proprio uso.
Per altro questo metodo è presente fin dal sottotitolo del libro, laddove si sbandiera la «guerriglia urbana femminista» pur sapendo che tale termine venne anche criticato dalle Rote Zora verso la fine della loro esperienza («oggi il piano di guerriglia non è il nostro traguardo, poiché è orientato a conseguire la conquista del potere attraverso formazioni militari. Noi non vogliamo conquistare il potere patriarcale, bensì distruggerlo. La storia ci insegna che la conquista del potere, realizzata per mezzo di formazioni militari autonome, è soltanto un cambio di dominio patriarcale»). Dal che se ne deduce che l’autocritica delle Rote Zora sarà anche lodevole, ma non tenerne conto è strumentale.
Questi controsensi non scivolano indisturbati durante la lettura, si agitano sotto i miei occhi dandomi la nausea come il fetore emanato dalla brodaglia riscaldata con fervore dalle curatrici di questo libro: il potere è solo quello degli «uomini», i quali scrivono la «storia ufficiale» e «si considerano rappresentativi dell’umanità». Poiché siamo nel 2018, mi sembra che si tratti di ottime considerazioni se si vuole fare della lotta contro il patriarcato una barzelletta. Altrimenti è impossibile negare che anche il potere non ha genere, e quindi in quanto tale piace non solo alle eterosessuali come Angela Merkel o Hillary Clinton, ma pure a bisex come la governatrice dell’Oregon Kate Brown o la senatrice del South Dakota Angie Buhl, e persino a lesbiche come la governatrice dell’Ontario Kathleen Wynne o l’ex premier islandese Jóhanna Sigurdardóttir (per non parlare della casereccia deputata Paola Concia, la cui pratica lesbica della teoria femminista non le ha impedito di approcciarsi occasionalmente a CasaPound). Ma poiché questi sono alcuni dei «nodi» odierni che guasterebbero il consumo della «narrazione» — il cui scopo è suscitare tacita ammirazione, mica riflessione critica —, si preferisce trascurarli.
Incredibile è poi la disinvoltura con cui nell’introduzione viene abbordata la questione della violenza liberatoria delle donne. In Italia «a partire dagli anni 70, nel movimento delle donne si assiste ad un rifiuto dell’uso della violenza», con conseguente «allontanamento e presa di distanza dalle donne che ne fanno uso». Quali donne? Ma «le militanti delle organizzazioni combattenti», ovviamente, come quelle evocate nel libro Mara e le altre. Buono a sapersi che il punto di riferimento storico delle curatrici del libro, per la loro analisi sull’uso della violenza delle donne contro il patriarcato qui in Italia, è il rapporto intercorso negli anni 70 fra la politica del femminismo e le staliniste armate. Approccio casuale o approccio di parte? Fatto sta che su quel vecchio libro di sinistra è effettivamente possibile reperire tracce poco note della rabbia femminile dell’epoca: «È difficile considerare la consistenza di questi gruppi che sfuggono a qualsiasi sommaria classificazione, così come a qualsiasi radiografia o mappa, del resto necessariamente imprecisa o poliziesca. Non si tratta infatti di gruppi organizzati in modo costante, con una vita politica legata esclusivamente alla preparazione e alla messa in opera delle azioni, quanto piuttosto di gesti e azioni sporadici e spontanei, di gruppi che si coagulano, nascono e si organizzano in occasione di un determinato e specifico obiettivo, per poi sciogliersi. E tutto questo è dimostrato, tra l’altro, anche dalla varietà e dalla non continuità delle firme, molte delle quali sono addirittura degli slogan e come tali intendono rappresentare uno stato d’animo di ribellione piuttosto che un’avanguardia costituita da donne armate». Edotte da queste esperienze, le curatrici del libro sulle Rote Zora giungono alla conclusione che «Sicuramente in Italia non si sviluppa un gruppo femminista di guerriglia urbana strutturato a lungo termine come le Rote Zora. Tuttavia, come nella RFT, le azioni dirette illegali e in generale la riappropriazione della violenza, intesa come necessità di autodifesa dall’oppressione patriarcale, sono sicuramente parte integrante del percorso politico di molte femministe».
Una logica impeccabile, che va però riassunta per assaporarla in pieno. Dunque, anche qui in Italia la politica del «movimento delle donne» rifiutava l’uso della violenza, ma molte donne in carne ed ossa no. Alcune di loro entrarono nel Partito armato, dove l’ortodossia pretendeva si avessero occhi solo per la classe operaia. Molte altre invece, senza il contributo delle «militanti combattenti», passarono all’azione diretta. E, come fanno notare le curatrici, lo fecero al di fuori di un gruppo strutturato a lungo termine, ovvero in maniera del tutto informale e anonima. L’osservazione è mooolto interessante, però fa scattare un’ovvia domanda destinata a restare senza risposta: ma allora, stante così la situazione, perché farsi in quattro per rispolverare i gruppi strutturati stranieri quando sarebbe stato più immediato tirare fuori dal dimenticatoio la selva oscura che cresceva sotto casa? Forse perché non è tanto la rabbia femminile che «agisce violenza» ad attirare chi narra ideologia, quanto la sua possibile rappresentazione politica?
Sono cattiva, lo so. D’altronde perfino Marguerite Yourcenar si riferiva ai soli uomini quando affermava che «non bisogna esagerare con l’accusa di ipocrisia, la maggior parte pensa troppo poco per pensare doppio». Sono poco generosa, lo so. Più di tanto dalle ammiratrici di Mara e le altre non posso pretendere, già hanno dovuto rinunciare al grande Partito a favore delle piccole bande, già non scordano di fare l’immancabile occhiolino alle teorie libertarie concedendo che «continua ad essere attuale l’urgenza di una tensione antiautoritaria che individui nello Stato e nei suoi tentativi di assimilare le lotte un chiaro nemico» (che appena il venticello muterà direzione e l’antiautoritarismo diventerà rimandabile, si potrà passare a ben altra attualità). Mantenessero un minimo di contegno logico, sarebbero più plausibili.
Mi ritrovo invece a leggere assurdità come questa: «il monopolio della violenza patriarcale che a livello istituzionale è in mano a esercito e apparato repressivo, a livello sociale è in mano agli uomini. Storicamente le donne sono state escluse da questo monopolio, il cui scopo è proprio quello di sottometterle». Frase che vorrebbe essere chiara, ma che produce solo un cortocircuito mentale. Il monopolio istituzionale della violenza non è affatto precluso alle donne in quanto tali (basti pensare a quante donne etero, bisex e lesbiche, fanno parte di eserciti ed apparati repressivi, anche in posti di comando). Il monopolio della violenza patriarcale è ovviamente precluso alle donne, tanto quanto quello della violenza matriarcale lo sarebbe agli uomini. Ma il problema a mio avviso non è quello di venire «incluse» nel monopolio della violenza, quanto di porre fine a qualsiasi monopolio. Dato che lo scopo di ogni monopolio della violenza è di sottomettere qualcuno, chiunque sia, per quanto mi riguarda è un vanto il non volerlo esercitare. Bisognerebbe lasciare ai più infami degli uomini e alle più infami delle donne l’ambizione di possedere questo infame privilegio, sia esso praticato da militari che da amazzoni. Sfidare tale monopolio è un passo minimo per ogni percorso di liberazione, ma il fine di questa sfida non è affatto sostituire un monopolio con un altro monopolio, oppure ottenere un duopolio, quanto restituire ad ogni singolo individuo la possibilità di usare la forza. Le compagne di Rote Zora lo avevano capito perfettamente («Secondo noi il potere è inscindibilmente connesso al dominio, perciò vogliamo combattere il dominio patriarcale e arginare il potere. Con lo slogan “Potere alle donne!” esprimiamo la voglia di diventare più forti, di farci valere, ma così facendo trascuriamo il fatto che esercitare il potere ha sempre e soltanto significato dominare. Se facciamo il paragone linguistico “Potere alle donne” – “Potere ai dominanti” ci rendiamo conto di quanto i concetti che usiamo siano inesatti e poco ragionati e di quanto abbiamo interiorizzato il pensiero patriarcale… consideriamo inutilizzabile il concetto di potere nella descrizione della nostra politica e dei nostri scopi e di conseguenza lo impieghiamo soltanto in riferimento ai rapporti dominanti. Non vogliamo né prendere il potere, né misurare le nostre forze sullo stesso piano dell’avversario»), le militanti combattenti staliniste no, le ammiratrici odierne un po’ delle une e un po’ delle altre (a seconda dell’attualità dell’urgenza o dell’urgenza dell’attualità)… boh.
E non posso fare a meno di chiedermi come si possa trarre ispirazione dalle Rote Zora per agire «oltre i limiti della legge ma anche lontano dalle istituzioni, in autogestione e orizzontalità… anche fuori dagli schemi femminili prestabiliti dalla norma patriarcale», quando poi si interpretano le loro idee alla luce di concetti forgiati da chi serve le istituzioni. Possiamo definire le analisi delle Rote Zora «intersezionali» solo ficcandoci in testa e in bocca questo termine coniato nella facoltà di giurisprudenza di una università degli Stati Uniti. Non basta che l’autrice sia donna e per di più nera (due minoranze oppresse in un solo corpo! la buona coscienza bianca occidentale trema dall’emozione ed ammutolisce per i sensi di colpa) per renderlo appetibile. Allo stesso modo, «assumendo le elaborazioni dell’analisi trans — possiamo chiamare cisgenere» il soggetto politico femminista a cui le Rote Zora si riferivano — certo, a patto di pensare che ripetere dei tecnicismi (magari escogitati da un sessuologo maschio) significhi saperla più lunga.
Quanto a me, rimpiango Voltairine de Cleyre e le sue semplici parole contro la costruzione del ruolo di genere pronunciate nel 1890, e sputo sulle odierne chieriche dei gender studies e sul loro insopportabile gergo cattedratico condito con la loro supponenza di genere.
Suona poi alquanto sibillina la brusca puntualizzazione fatta dalle curatrici di questo libro: «Lo diciamo fuori dai denti: se si guarda con diffidenza a lotte e pratiche femministe ci si scordi di elogiare le Rote Zora perché usavano la dinamite. Un’analisi non superficiale dell’oppressione patriarcale ci porta inevitabilmente anche ad un percorso di autocoscienza e di cambiamento personale, i quali trovano espressione in forme altre rispetto al puro attacco. Negare o minimizzare questo fatto equivale a non comprendere la complessità della lotta femminista. Quest’ultima ha molti volti, e ovviamente non tutti ci rappresentano. Tuttavia crediamo che la discussione riguardo ai metodi da impiegare per lottare contro il patriarcato debba essere fatta tra chi ha nel proprio orizzonte l’urgenza del suo abbattimento». Non capisco bene con chi ce l’abbiano, presumo con quelle compagne capaci di infiammarsi per le Rote Zora ma freddine verso la psicanalisi di gruppo (benché le stesse Rote Zora criticassero il percorso intimista intrapreso dal femminismo). Oppure si tratta di un velato invito a non storcere il naso di fronte alla sorellanza neo-moderna, quella che compie il miracolo compositivo di far sedere fianco a fianco donne pro-abortiste e donne anti-abortiste? Nel dubbio, lo dico anch’io fuori dai denti: un’analisi superficiale dell’oppressione patriarcale porta inevitabilmente al rispetto per tutte le lotte e le pratiche femministe. Se in nome della loro complessità non si guarda con ostilità a certe lotte e pratiche femministe, soprattutto a quelle accademiche, desistenti e filo-istituzionali, ci si scordi di elogiare le Rote Zora perché usavano la dinamite.
Mentre faccio queste riflessioni, continuo ad interrogarmi sulla bontà dell’intenzione che evoca il ritorno del femminismo militante. Le Rote Zora sono scomparse nel 1995. Da allora il panorama sociale si è modificato vorticosamente. Sotto il dominio tecnologico, la stessa storia è diventata un archivio di dati manipolabili all’infinito: fatti e persone, ragioni e passioni, tutto frantumato, separato, omologato, incrociato, ricombinato. Riconfigurazioni che si susseguono ad una velocità tale da rendere pressoché inutile lo sforzo di assegnare un senso preciso a quanto ci circonda, il che spiega il motivo per cui oggi non si facciano più discussioni ma al massimo delle «chiacchierate», come se si considerasse una perdita di tempo soffermarsi a riflettere su ciò che nel giro di un attimo potrebbe già essere cambiato. Ecco perché siamo infestati da «narrazioni» che lisciano il pelo al passato per non dire nulla sul presente, lisciano il pelo al presente per non dire nulla sul futuro, lisciano il proprio pelo e basta. Come si scusano le curatrici del libro sulle Rote Zora, «assumersi la complessità del reale è imprenscindibile, nonostante ciò non possiamo sciogliere tali nodi in queste poche righe». Più che non scioglierli, non vengono toccati neanche di striscio.
Faccio un paio di esempi. Le Rote Zora attaccavano i negozi di materiale pornografico, per protestare contro la mercificazione e l’umiliazione del corpo femminile. Ma oggi una parte del femminismo non è affatto contraria all’industria pornografica, anzi. Ora, la discrepanza è tale da non lasciare molto margine agli equilibrismi: o le vecchie femministe delle Rote Zora erano delle bigotte, oppure le nuove femministe 3.0 hanno introiettato un certo immaginario consumistico maschile. Pensare di scavalcare questa eclatante contraddizione con una frettolosa noterella editoriale riservata all’anteprima della presentazione («ci teniamo a specificare che in alcune correnti del femminismo sono state portate avanti riflessioni su un altro possibile ruolo dei sexy shop e sulla riappropriazione della pornografia. Per esempio sono nati i sexy shop per donne!») non è solo imbarazzante, è penoso.
Un altro esempio è dato dall’attacco frontale ai capisaldi del femminismo da parte di alcune donne originarie di paesi non occidentali, ovvero di quei paesi i cui movimenti di lotta vengono difesi a spada tratta dagli anti-imperialisti. Penso a Houria Bouteldja, ad esempio, il cui libro è stato pubblicato qui in Italia proprio dalla casa editrice fondata da… il consorte di Mara (mentre in Francia è stato pubblicato dal versatile editore del Comitato Invisibile). Se una donna bianca occidentale avesse pubblicato un libro in cui sostiene con orgoglio che il suo corpo non le appartiene, giacché appartiene alla sua famiglia, al suo clan, al suo quartiere, alla sua razza, alla sua nazione, alla sua religione… e che quindi le donne oppresse stuprate devono difendere i propri stupratori, se appartenenti alla stessa comunità, per non darli in pasto alla giustizia dei padroni (ops, è più o meno quanto sostenuto dalle Miserabili Donne di Merda contro la ragazza stuprata a Parma)… beh, sarebbe stata subissata dagli insulti, come meriterebbe ogni becera oscurantista reazionaria. Ma se a sostenerlo è una militante franco-algerina del movimento decoloniale, allora… allora per lei si aprono i cataloghi delle case editrici di estrema sinistra, si aprono i microfoni delle radio di estrema sinistra, si aprono le porte degli spazi (di delatori) di estrema sinistra.
Ecco, non sono sicura che le analisi anti-imperialiste delle Rote Zora siano di grande aiuto a questo proposito, con o senza citazioni di Rosa Luxemburg. Ma chi manifesta così tanta «urgenza» ad abbattere il patriarcato farebbe bene ad affrontarla, tale questione (soprattutto considerato che Bouteldja ha ricevuto il sostegno di una esponente del movimento LGBT come l’attrice Océanerosemarie). Solo che, per riuscirvi, temo che dovrà dire addio alle narrazioni facili da smerciare e consumare, per dedicarsi ad un pensiero critico sicuramente più ostico da diffondere ed approfondire.
Come dicevo all’inizio, a quanto pare il femminismo militante sta tornando in auge, per lo meno sulla carta… Grande è la confusione sotto i cieli. La situazione è tragicomica.
[11/6/18]
fonte: finimondo.org